I Rohingya, un popolo dimenticato due volte
- Angelo Soro
- 30 ago 2025
- Tempo di lettura: 11 min
Il limbo di una popolazione senza patria

Foto GMB Akash
“Le persone al di fuori del Bangladesh e del Myanmar devono capire che la crisi dei Rohingya non è solo una storia di sfollamento, riguarda vite umane reali, famiglie divise, generazioni che crescono nell’incertezza e nella paura. Sono persone con sogni, speranze e dignità, eppure vivono in estrema vulnerabilità.”
Con queste parole, il fotografo e giornalista GMB Akash descrive l’impatto umano di una delle crisi più trascurate del nostro tempo. Dal 2017 a oggi, centinaia di migliaia di Rohingya, una minoranza musulmana perseguitata in Myanmar, vivono in campi profughi al confine con il Bangladesh.
Kutupalong, situato nel distretto costiero di Cox's Bazar, nella parte sudorientale del Bangladesh, è attualmente il più grande campo profughi del mondo, con i suoi quasi 13 chilometri quadrati. Ospita circa un milione di rifugiati, prevalentemente Rohingya, fuggiti dalle violente persecuzioni nel vicino Myanmar.
Kutupalong non è solo il campo più grande del mondo, è anche il più densamente popolato, con una stima tra 48.000 e 76.000 persone per chilometro quadrato, e ha superato da tempo la sua capacità ricettiva.
La maggior parte dei rifugiati non ha un accesso adeguato ad acqua pulita, servizi igienici o assistenza sanitaria. Le stagioni dei monsoni rappresentano inoltre un'enorme minaccia per migliaia di famiglie Rohingya che vivono in rifugi di fortuna nel campo.
La malnutrizione, le malattie intestinali come colera e diarrea e l’accesso limitato alle cure mediche mettono a rischio la vita di molti bambini e anziani (UNHCR). L’istruzione è frammentaria: molte scuole sono improvvisate e la frequenza scolastica è incostante a causa delle difficoltà economiche e della necessità di lavoro minorile. La salute mentale è gravemente compromessa: i traumi della fuga, della violenza e della vita nei campi generano ansia, depressione e disturbi post-traumatici diffusi tra adulti e bambini.
Oggi, nel 2025, la loro situazione è più disperata che mai. Eppure, il silenzio intorno a questa tragedia è calato da tempo e sembra essersi solidificato attorno alle tende e alle baracche improvvisate del campo.
Una crisi dimenticata
I Rohingya sono una minoranza musulmana che vive principalmente nello Stato di Rakhine, in Myanmar. La loro presenza nella regione risale a secoli fa, con una cultura distinta, lingua propria e tradizioni religiose musulmane (BBC).Nonostante ciò, lo Stato birmano non li riconosce come cittadini: la Legge sulla cittadinanza del 1982 li esclude formalmente, privandoli di diritti fondamentali come la libertà di movimento, il lavoro e l’accesso ai servizi pubblici.
La persecuzione dei Rohingya è cronica: violenze, discriminazioni e restrizioni sono iniziate già negli anni ’70 e ’90, con campagne militari che hanno provocato migliaia di sfollati, prima della crisi massiva del 2017 (Human Rights Watch).
Nel 2024 e 2025, una nuova ondata di violenze ha costretto altri 150.000 Rohingya alla fuga dalle loro abitazioni nel Myanmar.Ora più che mai le risorse scarseggiano e i fondi internazionali si stanno prosciugando.Le razioni alimentari sono state ridotte della metà. In molti casi, non ci sono medicine, scuole e accesso all'acqua potabile (fonti: UNRIC, Washington Post, Reuters).
Il Bangladesh, sotto pressione, ha iniziato a respingere i nuovi arrivati alla frontiera, violando il principio di non-refoulement (fonte: Human Rights Watch), che è un pilastro fondamentale del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, in particolare nel contesto della protezione dei rifugiati.
Non-refoulement (dal francese: “non respingimento”) significa che nessun rifugiato o richiedente asilo può essere rimandato in un paese dove rischia persecuzioni, torture o gravi violazioni dei diritti umani.È principio sancito dall’articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati:
“Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà (‘refouler’) un rifugiato verso le frontiere di territori dove la sua vita o la sua libertà sarebbe minacciata.”
Tutti gli Stati, anche quelli che non hanno ratificato la Convenzione del 1951, devono applicare il principio di non-refoulement perché è considerato diritto internazionale consuetudinario.E vale indipendentemente dallo status legale del rifugiato: anche se entrato illegalmente non può essere espulso se questo lo mette in pericolo.
Un clima di terrore tra i rifugiati
Nei campi, gruppi armati come l’ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) e l’RSO (Rohingya Solidarity Organization) contribuiscono a un clima di paura e violenza, spesso costringendo i rifugiati a unirsi alle milizie in cambio di aiuti.
L’ARSA è un gruppo armato etnico-rohingya, emerso pubblicamente nel 2016, guidato da Ataullah Abu Ammar Jununi, nato in Pakistan e cresciuto in Arabia Saudita. Rivendica l’obiettivo di proteggere i Rohingya dalla persecuzione in Myanmar.
Più vecchio dell’ARSA è il RSO, nato negli anni ’80, con radici islamiste e legami storici con combattenti in Afghanistan e Pakistan. È stato inattivo per anni ma ha ripreso l’attività nel 2023‑2024.
Negli ultimi anni, sia ARSA sia RSO, sono stati collegati a numerosi atti di violenza all’interno dei campi rifugiati Rohingya, in particolare a Kutupalong.Le violenze segnalate includono intimidazioni, estorsioni, rapimenti e omicidi. Secondo il rapporto di Fortify Rights, tra il 2021 e il 2024 sono state documentate almeno 219 vittime di omicidi perpetrati nei campi da questi gruppi armati (fonti: Radio Free Asia e Fortify Rights).
Sono inoltre emersi episodi di reclutamento forzato di giovani e minori, spesso ottenuto con minacce, intimidazioni o persino in cambio di razioni alimentari. Questi metodi di coercizione vengono utilizzati sia da ARSA sia da RSO (fonte: Dahka Tribune).Parallelamente, entrambi i gruppi sono stati coinvolti in attività illecite, tra cui traffico di droga, armi e esseri umani.Il loro controllo su alcune zone dei campi è particolarmente marcato durante le ore notturne, quando i miliziani impongono la propria autorità attraverso violenza e intimidazioni (fonte: The Daily Star).
Un fatto drammatico che esemplifica la crescente influenza e brutalità di questi gruppi è l’assassinio di Mohib Ullah, noto attivista Rohingya per i diritti umani e presidente dell’Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights.È stato brutalmente ucciso il 29 settembre 2021 nel campo di Kutupalong.Indagini della polizia del Bangladesh e inchieste giornalistiche indicano che il suo omicidio fu ordinato da Ataullah Abu Ammar Jununi, leader di ARSA, perché Mohib Ullah ostacolava il loro controllo sui campi (fonte: Radio Free Asia).
La situazione dei Rohingya in Myanmar
All’interno del Myanmar, la situazione resta tragica.I Rohingya si trovano intrappolati tra due fuochi: da una parte la giunta militare, dall'altra i gruppi armati.
Molti vivono in campi di internamento, senza libertà di movimento, senza cibo sufficiente e senza assistenza medica. Human Rights Watch afferma che ci sono stati almeno 25 morti per fame solo nei primi mesi del 2025 (fonte: HRW World Report).
Secondo quanto riportato da HRW, “[...] la giunta birmana ha compiuto esecuzioni extragiudiziali su larga scala. Il 29 maggio, i soldati hanno radunato centinaia di abitanti del villaggio di Byain Phyu, nello stato di Rakhine, separando uomini e donne.I residenti sono stati interrogati e torturati; alcuni sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Secondo quanto riferito, l'esercito ha ucciso tra i 48 e i 76 abitanti del villaggio, tra cui cinque donne che sono state anche violentate. Ad agosto, due giornalisti sono stati uccisi durante un raid militare nello stato di Mon.[...]”
La cosiddetta "pulizia etnica" non si è mai interrotta: continua sotto forma di persecuzione sistematica, segregazione, negazione della cittadinanza e blocco degli aiuti umanitari (fonti: UNRIC e Reuters).
Oggi i Rohingya rifugiati in Bangladesh vivono in una sorta di limbo: i governi regionali, le Nazioni Unite e le ONG continuano a fare appelli per una soluzione duratura, ma la mancanza di un rientro sicuro in Myanmar e la scarsità di risorse rendono la vita nei campi sempre più difficile da gestire (fonte: UNRIC).
Il ritorno in Myanmar rimane pressoché impossibile a causa di una serie di ostacoli strutturali e politici. Innanzitutto, la legge sulla cittadinanza del 1982 esclude formalmente i Rohingya dal loro riconoscimento come cittadini birmani, riducendoli a immigrati illegali e negando loro qualsiasi garanzia legale.Senza un cambiamento normativo, anche in caso di rientro, rimarrebbero un popolo apolide e privo di diritti fondamentali.
A questo si aggiunge la persistente insicurezza nello Stato di Rakhine, dove l’esercito birmano e gruppi armati come l’Arakan Army continuano a scontrarsi, lasciando i civili, inclusi i Rohingya, intrappolati in un clima di violenze, tra arresti arbitrari e abusi sistematici (fonte: Human Rights Watch).Molti villaggi rohingya sono stati distrutti durante le offensive militari del 2017 e degli anni successivi, rendendo materialmente impossibile per migliaia di famiglie tornare nelle proprie terre.
Un ulteriore ostacolo è rappresentato dalla resistenza della popolazione maggioritaria in Myanmar, in gran parte buddista, che in molti casi considera i Rohingya come “stranieri” provenienti dal Bangladesh.Questo radicato sentimento di ostilità alimenta il rischio di nuove persecuzioni in caso di rimpatrio.
Infine, anche gli accordi bilaterali tra Bangladesh e Myanmar per il rimpatrio dei rifugiati si sono rivelati inefficaci.
I Rohingya stessi si rifiutano di tornare senza garanzie di sicurezza, cittadinanza e riconoscimento dei diritti, consapevoli che un rientro forzato significherebbe rivivere le stesse violenze che li hanno costretti a fuggire.
In sintesi, la combinazione di assenza di cittadinanza, insicurezza, distruzione dei villaggi, ostilità sociale e mancanza di garanzie politiche rende il rientro dei Rohingya non solo difficile, ma pericoloso.
Un testimone: G.M.B. Akash
Ho il privilegio di conoscere personalmente da tempo G.M.B. Akash, non solo come fotografo e reporter pluripremiato, ma come persona. In lui ho sempre visto una straordinaria umanità, che si riflette nel suo modo di raccontare i Rohingya: il suo sguardo non si limita a registrare i fatti, ma riesce a cogliere la dignità, il dolore e la speranza di chi vive questa tragedia.
Recentemente abbiamo avuto una interessante conversazione proprio sul tragico destino di quel popolo e su ciò che accade ai confini tra Bangladesh e Myanmar. Il nostro dialogo e le immagini che ha scattato durante uno dei suoi reportage al confine con il Myanmar, sono stati per me estremamente illuminanti e rappresentano una testimonianza di grande valore per comprendere la situazione dei Rohingya rifugiati in Bangladesh.
Ho chiesto ad Akash il permesso di pubblicare il contenuto della nostra conversazione e le sue immagini; quello che segue è il resoconto del nostro colloquio e le immagini inserite dopo l’intervista sono state gentilmente concesse da Akash per far comprendere in quali condizioni di disagio vivano i Rohingya.
Angelo Soro: Cosa ti ha portato per la prima volta nelle aree dei rifugiati Rohingya? Come hai iniziato a documentare questa crisi?
G.M.B. Akash: La mia prima volta nei campi profughi Rohingya è stata spinta dal desiderio di andare oltre i titoli dei giornali e comprendere davvero l’impatto umano della crisi. Leggevo di violenze e sfollamenti, ma sentivo il bisogno di vedere con i miei occhi e raccontare in maniera autentica le storie delle persone colpite dalla persecuzione.
Ho iniziato così: vivendo nei campi, parlando con le famiglie, ascoltando le loro esperienze e documentando la quotidianità. Ho sempre cercato di mettere al centro la resilienza e l’umanità, raccontando non solo le sofferenze, ma anche il coraggio con cui affrontano difficoltà estreme.
A.S.: Cosa hai visto nei campi e nelle zone di confine? Quali immagini ti sono rimaste più impresse?
G.M.B.: Nei campi e lungo i confini ho visto immenso dolore, ma anche una forza incredibile. Famiglie che avevano perso tutto, costrette a vivere in rifugi precari, alla ricerca disperata di cibo, acqua e sicurezza.
Eppure i bambini trovavano ancora il modo di giocare tra le macerie delle loro vite, con risate fragili ma piene di sfida.
Le immagini che porto dentro sono quelle più silenziose: una madre che stringe il figlio sotto la pioggia, una ragazzina che riesce a sorridere nonostante il trauma, un anziano che fissa l’orizzonte in silenzio, carico di ricordi di una casa che non esiste più. Scene che restano indelebili, perché racchiudono sia il dolore dello sradicamento che la forza dello spirito umano.
A.S.: Come è cambiata nel tempo la situazione dei rifugiati, soprattutto oggi, nel 2025?
G.M.B.: Quello che doveva essere un rifugio temporaneo è diventato una condizione quasi permanente. Oggi, nel 2025, nei campi di Cox’s Bazar vivono circa un milione di Rohingya. Le risorse sono sempre più scarse: gli aiuti umanitari sono in calo, le razioni alimentari si riducono, sanità ed educazione sono in crisi.
La comunità internazionale non ha garantito un sostegno costante. Così i rifugiati restano sospesi tra il trauma del passato e un futuro incerto. È la prova più evidente che il mondo deve agire: non solo per salvare vite, ma per restituire dignità.
A.S.: Qual è stata la tua esperienza come fotografo e giornalista in queste aree dal punto di vista pratico, emotivo ed etico?
G.M.B.: È un lavoro difficile su tutti i fronti. Logisticamente i campi sono affollati e difficili da raggiungere, con pochissime risorse. Emotivamente, l’impatto è enorme: convivere ogni giorno con sofferenze immense, ma anche con atti di coraggio e resilienza straordinari.
Sul piano etico, ogni fotografia è una responsabilità. Il mio obiettivo è sempre raccontare con rispetto e dignità, evitando ogni forma di sfruttamento. Non si tratta solo di mostrare la sofferenza, ma di trasmettere al mondo la loro realtà, fatta di dolore ma anche di umanità.
A.S.: Il mondo ha dimenticato la crisi dei Rohingya? Perché, secondo te, i riflettori si sono spenti?
G.M.B.: Non credo che il mondo abbia dimenticato del tutto, ma è inevitabile che l’attenzione mediatica si sposti altrove col tempo. Le crisi che durano anni finiscono per sparire dai titoli, anche quando la situazione rimane drammatica.
Per questo è fondamentale che giornalisti, fotografi e narratori continuino a condividere queste storie. Solo così il mondo potrà ricordare i volti umani dietro le statistiche e capire che la loro lotta non è finita.
A.S.: C’è una storia che ti ha particolarmente colpito, che non dimenticherai mai?
G.M.B.: Non dimenticherò mai una madre che ho visto attraversare il confine in un campo di riso allagato, sotto la pioggia. Stringeva il suo neonato, piangendo disperatamente perché non aveva latte per nutrirlo. Era in cammino da tre giorni, senza quasi cibo, ma continuava a fare di tutto per il suo bambino.
Nei suoi occhi c’erano stanchezza, paura e un amore feroce. Poco dopo venne soccorsa dalle guardie di confine del Bangladesh, ma quell’immagine - così cruda e potente - resterà con me per sempre.
A.S.: Come riesci a convivere con tutto il dolore e l’ingiustizia che hai visto?
G.M.B.: Non è facile. Porto dentro di me queste esperienze, che spesso mi rendono triste, scoraggiato, perfino fragile. È un lavoro che mette a dura prova anche la salute mentale.
Cerco però di trasformare queste emozioni nel mio lavoro. La fotografia e il racconto diventano un modo per dare voce a chi ho incontrato, per rendere visibile la loro lotta. Mi sforzo di trovare momenti di speranza anche nella sofferenza: vedere coraggio, amore e solidarietà in condizioni estreme mi aiuta a rimanere saldo e motivato.
Ho scelto di fare il mestiere di reporter perché credo che sia necessario continuare a raccontare queste storie.
A.S.: Cosa dovrebbero capire le persone che vivono fuori dal Bangladesh e dal Myanmar?
G.M.B.: Devono capire che non si tratta solo di una questione di sfollamento: riguarda vite spezzate, famiglie divise, generazioni intere cresciute nella paura e nell’incertezza.
Queste persone hanno sogni, speranze, dignità, ma vivono in una vulnerabilità estrema.
E bisogna capire anche un’altra cosa: questa è una crisi a lungo termine. Anche quando i giornali smettono di parlarne, la loro lotta continua.
È fondamentale che il mondo mantenga attenzione e solidarietà, non solo per garantire la sopravvivenza, ma per restituire dignità, sicurezza e futuro a queste comunità.
A.S.: Credi che le persone comuni - lettori, attivisti, artisti - possano fare qualcosa per mantenere viva l’attenzione su questa crisi?
G.M.B.: Ognuno può fare la sua parte. Raccontare storie, condividere fotografie ed esperienze umanizza la crisi e ricorda al mondo che essa continua.
Si può sostenere chi porta aiuti, fare pressione per cambiamenti politici o usare l’arte per dare voce a queste comunità.
Anche i gesti più piccoli - come sensibilizzare la propria comunità o parlare del tema sui social - contribuiscono a un movimento più ampio fatto di attenzione ed empatia.Ogni voce conta. Insieme possiamo fare in modo che la lotta dei Rohingya non venga dimenticata.
Foto gentilmente concesse da GMB Akash
Creative Commons – CC BY-ND 4.0
I contenuti di questo sito (testi, immagini e format del sito) possono essere condivisi liberamente, a condizione che venga citato l’autore e non vengano apportate modifiche.
Maggiori informazioni sulla licenza qui.









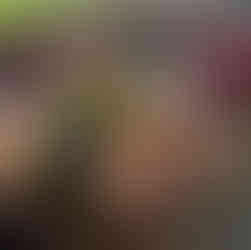











Commenti